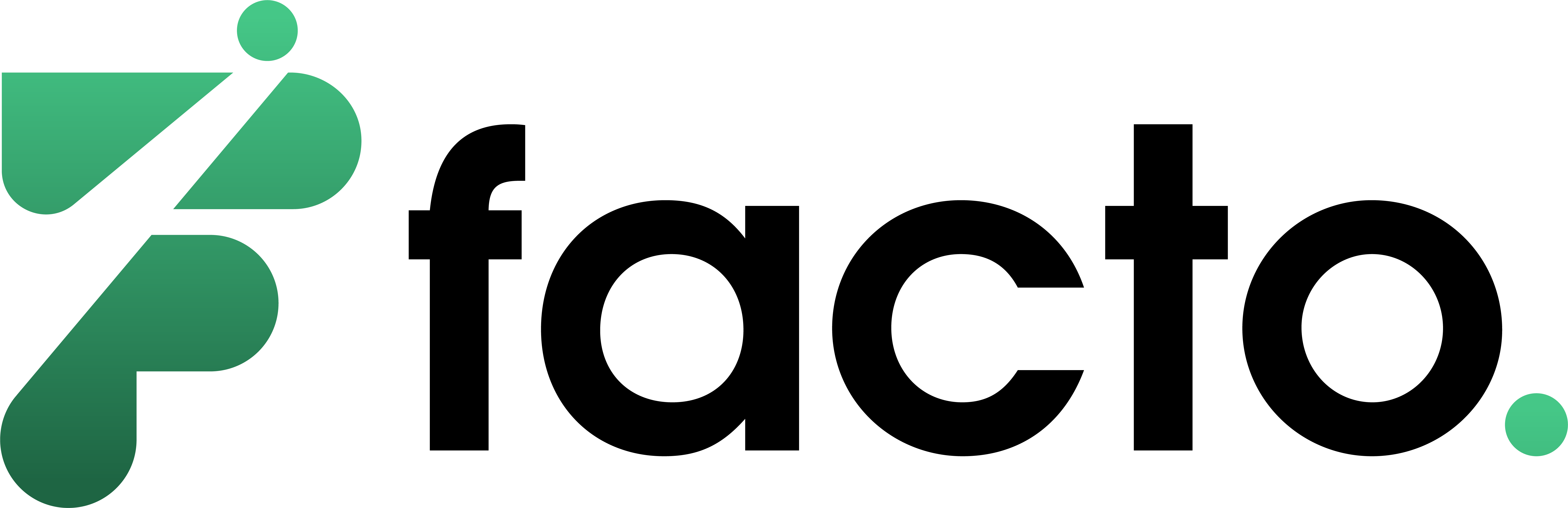Un coach empatico e non convenzionale
La serie Apple TV+ Ted Lasso racconta di un allenatore di football americano trapiantato in Inghilterra per guidare una squadra di calcio, ma in realtà mette in scena molto più di una storia sportiva. Sin dal primo episodio, Ted Lasso si distingue per un approccio relazionale e ottimista fuori dagli schemi tradizionali: è gentile con tutti, persino con chi lo tratta con ostilità, e cerca sempre di comprendere e valorizzare le persone invece di umiliarle. Invece di impostare la leadership sulla paura o sull’autorità, Ted punta su empatia, umorismo e autenticità. Pur non conoscendo a fondo il calcio, si affida a ciò che sa fare bene: creare legami e mostrare sincera attenzione verso i suoi giocatori, nella speranza che un incoraggiamento gentile produca risultati concreti. Questo stile non convenzionale – più vicino a quello di un mentore comprensivo che a un coach autoritario – rappresenta il cuore educativo della serie.
Ted Lasso incarna molte qualità di quella che in pedagogia si definisce “guida empatica”. Mostra di saper incontrare gli apprendenti dove si trovano, adattando il proprio supporto ai bisogni di ciascuno. Come afferma un insegnante ispirato da Ted, il segreto è “incontrare continuamente gli studenti dove sono, cercando di capire di cosa hanno bisogno e accompagnandoli fino al traguardo”. Allo stesso modo, Ted cerca di capire il vissuto di ogni atleta (paure, motivazioni, carattere) e calibra il suo coaching di conseguenza. Questo ricorda da vicino l’approccio centrato sulla persona teorizzato dallo psicologo umanista Carl Rogers: mettere al centro lo studente (o in questo caso l’atleta) riconoscendone l’unicità e creando un clima “aperto e privo di giudizio” in cui possa esplorare e imparare. Ted, infatti, tratta ogni giocatore come una persona di valore, indipendentemente dal rendimento sul campo o dagli errori commessi. Questa assenza di giudizio e positività incondizionata verso l’altro richiama il concetto rogersiano di unconditional positive regard (considerazione positiva incondizionata), quell’atteggiamento per cui “ognuno merita cura e rispetto a prescindere, anche quando sbaglia, perché l’errore non invalida il suo valore”. Non a caso, nel contesto educativo c’è chi definisce questo effetto come il “Ted Lasso effect”, riferendosi alla capacità di far sentire gli studenti (o i giocatori) al sicuro, protetti e sostenuti, così che possano trovare la motivazione per impegnarsi e crescere.
Apprendimento socio-emotivo in campo
Ted Lasso mette in primo piano l’apprendimento socio-emotivo – in inglese Social and Emotional Learning (SEL) – mostrando quanto siano cruciali le competenze emotive e relazionali per il successo di un gruppo. Nella serie vediamo i personaggi crescere non solo tecnicamente nello sport, ma soprattutto come persone: imparano a gestire le proprie emozioni, a fare squadra, a rispettarsi e sostenersi a vicenda. Questo è proprio l’obiettivo del SEL, un approccio educativo che punta a sviluppare intelligenza emotiva, abilità sociali e consapevolezza di sé negli individui, affinché possano prosperare a scuola, nel lavoro e nella vita. Tra le competenze socio-emotive essenziali promosse vi sono la consapevolezza di sé (capire i propri sentimenti e valori), l’autogestione emotiva (saper controllare impulsi e stress), la consapevolezza sociale (empatia verso gli altri), le abilità relazionali (saper comunicare, collaborare e risolvere conflitti) e il decision making responsabile. Nello spogliatoio dell’AFC Richmond queste capacità vengono allenate episodio dopo episodio: i giocatori apprendono a riconoscere le proprie fragilità (come l’ansia da prestazione o i problemi personali) e ad aiutarsi a vicenda, sotto la guida paziente di Ted.
Un esempio toccante di apprendimento socio-emotivo si ha nella crescita del personaggio di Jamie Tartt. Inizialmente è vanitoso e individualista, incapace di gestire le critiche o di fidarsi dei compagni. Attraverso l’approccio empatico di Ted e il sostegno del team, Jamie gradualmente impara l’umiltà e l’importanza di chiedere scusa e concedere perdono. Nella seconda stagione, dopo una difficile relazione con il padre, Jamie ha un crollo emotivo nello spogliatoio: invece di rimproverarlo, i compagni – guidati dal capitano Roy Kent – lo abbracciano in un gesto di solidarietà. Questa scena evidenzia il livello di sicurezza emotiva creato da Ted: la squadra è diventata una sorta di famiglia allargata dove ognuno può esprimere le proprie vulnerabilità senza paura, certo di trovare supporto. In termini pedagogici moderni, è un ambiente di apprendimento socio-emotivo ideale, in cui empatia e relazioni sane permettono a ciascuno di crescere caratterialmente oltre che professionalmente. Gli effetti positivi sono evidenti: i giocatori migliorano nelle prestazioni perché più concentrati e motivati, ma migliorano anche come persone, diventando più equilibrati e collaborativi – esattamente ciò che le ricerche sul SEL indicano come beneficio di un’educazione integrale delle emozioni e delle competenze sociali.
“Believe”: fiducia nel potenziale di ciascuno
Uno dei temi portanti di Ted Lasso è la fiducia nel potenziale dell’altro. Il simbolo di questo ethos è la celebre scritta “BELIEVE” che Ted appende nello spogliatoio: un monito costante a credere in se stessi e negli altri. Ted Lasso incarna il ruolo del mentore che sa vedere il meglio nascosto in ognuno, anche quando nessun altro se ne accorge. Un caso emblematico è quello di Nathan, il timido magazziniere della squadra: inizialmente ignorato e persino bullizzato, Nate viene notato da Ted, il quale ne apprezza le intuizioni tattiche e gli dà fiducia promuovendolo ad assistente. Questo atto di fiducia trasforma letteralmente Nate, che sboccia in sicurezza e competenza quando finalmente qualcuno crede in lui. Anche se il percorso di Nate non è privo di inciampi, il messaggio è chiaro: aspettative positive e incoraggiamento possono far fiorire talenti nascosti – un’idea che trova riscontro nel cosiddetto effetto Pigmalione studiato in psicologia dell’educazione (le aspettative dell’insegnante influenzano il rendimento degli studenti).
Dal punto di vista delle teorie educative, la fiducia di Ted nei suoi giocatori richiama i principi di Rogers e Montessori. Carl Rogers sosteneva che ogni persona ha in sé le risorse per crescere e autorealizzarsi, se posta in un ambiente di accettazione e fiducia. Offrire considerazione positiva incondizionata significa comunicare all’altro: “io credo in te, nel tuo valore, indipendentemente dagli errori”. Questo atteggiamento alimenta l’autostima e la motivazione intrinseca di chi apprende. Maria Montessori, dal canto suo, parlava del bambino come “costruttore di se stesso” e faceva dell’incoraggiamento all’autonomia il fulcro del suo metodo. “Aiutami a fare da solo” è la frase montessoriana simbolo: l’educatore deve fornire strumenti e supporto, ma anche mostrare fiducia lasciando spazio all’iniziativa e all’errore. Nella serie, Ted incarna proprio questo stile: funge da facilitatore più che da istruttore, crea un ambiente dove i giocatori si sentono liberi di provare, sbagliare e riprovare, sapendo che il coach ha fede nelle loro capacità. Questo approccio non solo fa emergere il potenziale tecnico (come nel caso di Sam Obisanya che, incoraggiato da Ted, sboccia come leader in campo), ma favorisce anche lo sviluppo di un forte senso di fiducia reciproca all’interno del gruppo. Ciascun membro impara a credere nel compagno così come Ted crede in lui, innescando un circolo virtuoso di sostegno morale. Si tratta, in definitiva, di coltivare quella “atmosfera di sicurezza” che secondo gli esperti rende gli studenti più propensi a impegnarsi e migliorare, perché sanno di essere supportati e mai giudicati indegni. In Ted Lasso, questa fiducia nel potenziale umano è il collante che unisce la squadra e trasforma profondamente anche personaggi inizialmente cinici o insicuri.
Formazione reciproca e continua
Un altro aspetto affascinante della visione educativa in Ted Lasso è l’idea che imparare sia un processo reciproco e senza fine. La crescita non riguarda solo i giocatori guidati dal coach, ma anche il coach stesso e l’intero ambiente umano attorno alla squadra. Ted, pur essendo l’“insegnante” in senso lato, non smette mai di imparare – dal calcio (che inizialmente conosce poco), dai colleghi e persino dai suoi allievi. Questa dinamica rispecchia il principio per cui chi insegna impara insegnando, caro a molte pedagogie attive. Ad esempio, Ted impara dal suo assistente Coach Beard le finezze tecniche del soccer, impara dalla psicologa sportiva Dr. Sharon ad affrontare i propri demoni interiori (come gli attacchi di panico), e impara dai giocatori stessi lezioni di vita e di cultura (celebre la scena in cui scopre il valore del tè o alcune usanze britanniche, grazie alla sua curiosità verso il mondo dei suoi ragazzi).
In pedagogia progressista, John Dewey sosteneva che l’educazione non è una preparazione alla vita, ma è vita stessa: un processo continuo di crescita e sviluppo che dura tutta l’esistenza. Dewey vedeva l’apprendimento come un flusso incessante in cui esperienza e conoscenza si integrano, e in cui ogni nuova sfida diventa opportunità di evoluzione. In Ted Lasso troviamo questa idea nella costante evoluzione dei personaggi: nessuno è “arrivato”, tutti hanno margini di miglioramento e qualcosa da insegnarsi a vicenda. La formazione è reciproca: Ted trasmette ottimismo e strategie relazionali ai giocatori, ma allo stesso tempo assimila da loro nuove prospettive (ad esempio, grazie al confronto con atleti di culture diverse come Sam, sviluppa anche lui una maggiore apertura mentale). Allenatore e squadra crescono insieme, apprendendo l’uno dall’altro in un ciclo continuo. Questa dinamica riflette anche la teoria socio-costruttivista di Lev Vygotskij, per cui l’apprendimento avviene in un contesto sociale di interazione continua: ognuno nel gruppo può fungere da “facilitatore” per l’altro, aiutandolo a raggiungere un livello leggermente superiore al proprio attuale, all’interno di quella che Vygotskij chiamava la zona di sviluppo prossimale. Pensiamo a come i giocatori esperti guidano i più giovani, o a come lo stesso Ted talvolta lascia spazio ad altri di guidare (ad esempio, nominando un consiglio di leadership interno alla squadra). C’è sempre qualcuno più esperto in un ambito che può momentaneamente fare da tutor a chi è meno esperto, esattamente come descritto dal concetto di scaffolding introdotto dallo psicologo Jerome Bruner. Nel learning by doing collettivo della squadra, Ted Lasso mostra come ognuno sia al tempo stesso insegnante e allievo: il sapere non cala dall’alto in modo unidirezionale, ma si costruisce insieme, nell’interazione quotidiana. Questo spirito di formazione condivisa risulta molto efficace nel far emergere il meglio da tutti, perché ciascuno si sente parte attiva del processo e non mero esecutore di ordini. In termini bruneriani, Ted fornisce inizialmente ai suoi giocatori delle “impalcature” di supporto – motivazione, consigli, feedback positivi – ma poi gradualmente li vede diventare autonomi e addirittura capaci di sorreggersi a vicenda. È la concretizzazione sul campo dell’idea che “per educare serve un villaggio”, dove anche l’educatore è umilmente disposto a imparare.
Va aggiunto che Ted Lasso evidenzia pure l’importanza di una crescita personale continua sul piano emotivo. Ted stesso, dietro la facciata sempre sorridente, affronta momenti di crisi e capisce di dover lavorare su di sé – imparando, ad esempio, a chiedere aiuto quando necessario (come fa accettando la terapia con la Dr.ssa Sharon). Questo sottolinea un punto spesso citato in psicologia dell’educazione: un buon educatore è colui che riflette sul proprio operato e non smette mai di migliorarsi. Nella serie, vediamo Ted interrogarsi più volte (“Are you good at your job?” gli chiede la psicologa; e lui onestamente esita) e mettere in discussione alcune sue scelte. Tale umiltà riflessiva è una lezione importante: la crescita personale e professionale è infinita, e l’errore o l’insuccesso (le “partite pareggiate” nella metafora della serie) non sono fallimenti ma tappe da cui apprendere.
Oltre il modello autoritario: una leadership educativa
Forse la rivoluzione più evidente portata da Ted Lasso nel mondo – spesso rigido – del calcio professionistico è il superamento del modello autoritario. La cultura sportiva (come certa cultura scolastica tradizionale) talvolta esalta l’allenatore tirannico, tutto urla e disciplina ferrea, che mantiene le distanze gerarchiche con i subordinati. Ted ribalta questo schema: lui non grida (se non per incitare con entusiasmo), non punisce con metodi umilianti, non impone un’obbedienza cieca. Al contrario, costruisce autorevolezza tramite l’autorevolezza morale e l’esempio positivo, non tramite la paura. Scherza con i giocatori, li ascolta, li tratta da pari sul piano umano. Questo cambio di paradigma riflette le idee di pedagogisti come Maria Montessori, che criticava l’insegnante-padrone a favore di un insegnante-facilitatore. “Al centro dell’approccio Montessori c’è il ruolo dell’insegnante come facilitatore piuttosto che come figura autoritaria” – una descrizione che si adatta perfettamente allo stile di Ted Lasso. Egli crea un ambiente ordinato e stimolante (come l’ambiente preparato montessoriano), ma poi lascia che siano i ragazzi a esplorare soluzioni, a prendere iniziative sul campo, intervenendo solo per guidare quando serve. Non c’è traccia in lui del mister dispotico che urla dalla panchina: Ted semmai sdrammatizza la tensione con una battuta, o incoraggia un giocatore in crisi di fiducia con una pacca sulla spalla e parole di comprensione.
Anche John Dewey e gli educatori progressivi condannavano l’istruzione passiva e autoritaria – “l’approccio educativo classico basato sulla trasmissione dall’alto di conoscenze”, contrapposto a un approccio attivo e basato sull’esperienza. Ted Lasso incarna questa seconda via: invece di impartire ordini militareschi, coinvolge la squadra in esperienze condivise (dalle sessioni di problem solving tattico alle divertenti attività di team building, come la serata in cui giocano a freccette al pub). I giocatori non sono pedine ubbidienti, ma protagonisti pensanti del processo: Ted chiede spesso il loro feedback, li rende partecipi delle decisioni (emblematica la scelta di affidare ad un consiglio dei giocatori alcune questioni dello spogliatoio). Questo clima democratico rispecchia l’ideale di Dewey di una scuola come comunità partecipativa e di un rapporto educativo basato sulla cooperazione, non sulla coercizione.
Un beneficio chiave di abbandonare il modello autoritario, mostrato chiaramente nella serie, è il fiorire di un ambiente di fiducia e rispetto reciproco. Invece di temere l’errore come motivo di punizione, i giocatori dell’AFC Richmond imparano a vedere l’errore come lezione e occasione di crescita – perché sanno che il coach li sostiene comunque. Questo riduce l’ansia da prestazione e libera energie positive: la squadra gioca con il sorriso, con creatività e spirito di gruppo, qualità che spesso gli allenatori “sergenti” soffocano. In termini psicologici, potremmo dire che Ted adotta uno stile autorevole (supportivo ma fermo sui valori) anziché autoritario: ad esempio, non esita a stabilire principi importanti (come il rispetto per tutti, dalla star al magazziniere) e a richiamare all’ordine se qualcuno li infrange, ma lo fa dialogando e spiegando, non imponendo con la forza della posizione. Il risultato è una disciplina interiore nei giocatori – essi aderiscono alle regole perché ne capiscono il senso, non per paura della punizione.
Da Ted Lasso emerge dunque una visione della leadership molto vicina alle moderne teorie educative: una leadership di servizio e di cura, simile al servant leadership citato anche nei business studies. L’allenatore efficace non è un dittatore, ma un coach nel senso etimologico di “vettura”: uno strumento che porta le persone a destinazione. Ted incarna questo concetto mettendosi al servizio della crescita dei suoi giocatori, coltivando con ciascuno una relazione umana genuina. La serie dimostra che tale approccio non è affatto sinonimo di debolezza o ingenuità: al contrario, ottiene risultati concreti in termini di coesione e miglioramento. I momenti in cui la bontà di Ted sembra ingenua (talvolta derisa come eccesso di positività) vengono bilanciati dal fatto che egli ottiene il meglio dalle persone, trasformando anche i cinici in alleati leali. Perfino l’algida direttrice Rebecca, inizialmente intenzionata a sabotarlo, finisce per apprendere da Ted una lezione di perdono e umanità quando lui, con disarmante generosità, la perdona per i suoi intrighi. È un insegnamento potente: la gentilezza autentica e la comprensione possono sciogliere i conflitti meglio di urla e ricatti, creando un clima in cui tutti imparano dai propri errori con dignità.
Convergenze con le teorie pedagogiche
In definitiva, Ted Lasso offre un ritratto divulgativo ma incisivo di principi cari a diverse teorie pedagogiche e psicologiche del ‘900, calati nella cornice popolare di una squadra di calcio. Ritroviamo in Ted il clima di fiducia incondizionata di Carl Rogers, dove ogni allievo è accolto e mai giudicato, e la centralità della relazione umana come veicolo di cambiamento. Rivediamo i capisaldi di John Dewey nel learning by doing continuo della squadra e nell’idea che l’educazione sia esperienza e crescita costante, non trasmissione statica di nozioni. Tocchiamo con mano la teoria di Vygotskij quando osserviamo il gruppo che impara collettivamente, con i più esperti che aiutano i meno esperti a fare il passo successivo (si pensi a Roy Kent che da veterano guida i giovani, incarnando un “tutoraggio” alla zona di sviluppo prossimale). Assistiamo allo scaffolding di Bruner ogni volta che Ted fornisce sostegno emotivo e suggerimenti ai suoi giocatori per poi gradualmente lasciarli agire in autonomia una volta acquisita sicurezza. E abbracciamo in pieno lo spirito di Maria Montessori nell’abolizione del paradigma autoritario a favore di un educatore-facilitatore che osserva, guida con dolce fermezza e prepara un ambiente ricco di opportunità in cui i “bambini” (o atleti) possano imparare liberamente dai propri interessi e dalle interazioni.
Ted Lasso dimostra come questi principi, lungi dall’essere astratte teorie, possano tradursi in prassi quotidiana efficace perfino in un ambito competitivo come lo sport professionistico. La serie, con il suo tono leggero e ottimistico, porta al grande pubblico un messaggio pedagogico profondo: si può formare una squadra (o una classe, o un gruppo di lavoro) coltivando l’intelligenza emotiva, la fiducia e la cooperazione, senza ricorrere ad autoritarismi. Anzi, è proprio questo approccio relazionale e umanistico che sblocca il massimo potenziale di ognuno, creando un clima in cui imparare dagli altri è naturale e in cui il successo è inteso non solo come vittoria nel punteggio, ma come crescita personale collettiva. In un’epoca in cui scuole e aziende riconoscono sempre più l’importanza delle soft skills e del benessere emotivo, Ted Lasso ci ricorda – col sorriso e qualche lacrima – che alla base di ogni grande percorso di apprendimento ci sono empatia, rispetto e un pizzico di ottimismo. E che un bravo educatore, come un bravo allenatore, è semplicemente colui che crede nelle persone e le aiuta a credere in se stesse.