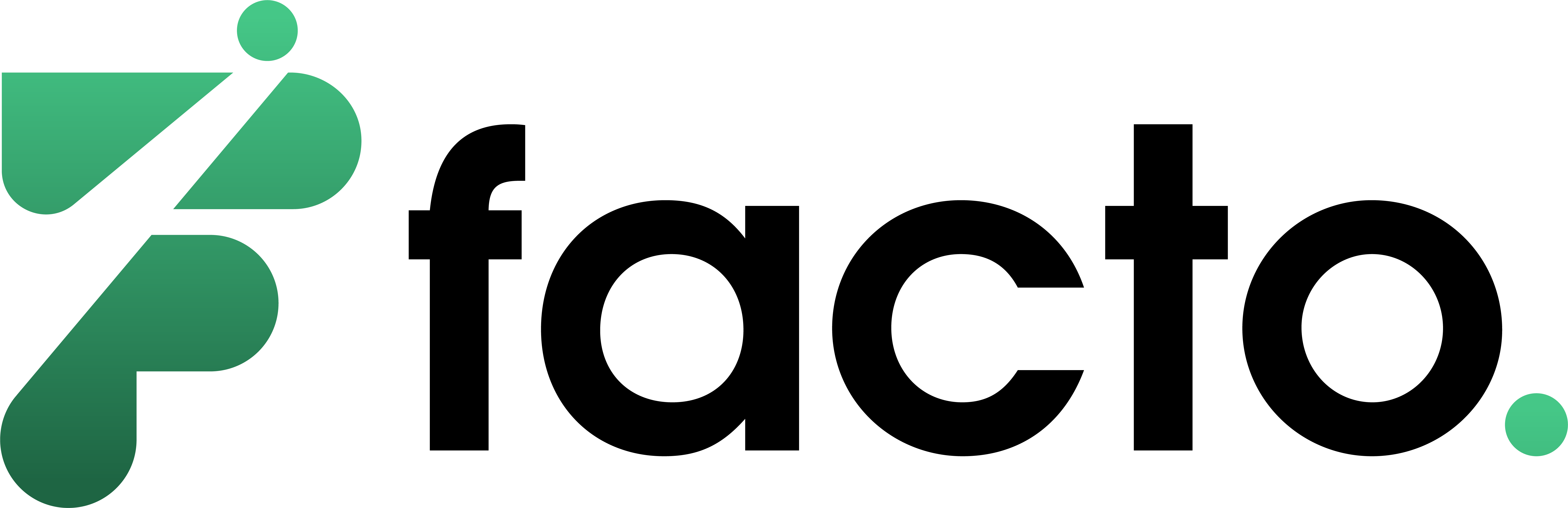Ambientata in un mondo in cui quasi tutti possiedono superpoteri (Quirk), la storia di My Hero Academia segue la crescita del giovane Izuku Midoriya (Deku) nella scuola U.A. High – il prestigioso liceo per aspiranti supereroi. Pur narrando di eroi e battaglie, My Hero Academia mette in scena dinamiche educative che possono interessare formatori, educatori e professionisti della crescita personale. In questo saggio divulgativo analizzeremo tre aspetti chiave in ottica pedagogica: (1) il metodo educativo e didattico della U.A. High School, (2) il ruolo formativo e simbolico di All Might come mentore, e (3) la motivazione personale di Izuku Midoriya (Deku), collegando ciascun aspetto a teorie della pedagogia e psicologia dell’apprendimento (Dweck, Bandura, Vygotskij, Bruner, etc.) dove rilevante. Il linguaggio sarà accessibile ma il contenuto denso, per trarre dal racconto fantastico intuizioni utili a chi, nel mondo reale, si occupa di educazione e sviluppo personale.
Il metodo educativo della U.A.: oltre la scuola tradizionale
La U.A. High School è presentata come la migliore accademia di eroi del Giappone, nota per formare i più grandi professionisti. Fin dal primo giorno è chiaro che la U.A. “non aderisce ai metodi scolastici tradizionali”, dando grande libertà ai docenti su come insegnare. Questa impostazione flessibile – in cui gli insegnanti, molti dei quali sono Pro Hero in attività, possono adottare metodi non convenzionali – incoraggia un approccio didattico innovativo e centrato sull’esperienza diretta. Ad esempio, Shota Aizawa (Eraserhead), insegnante e coordinatore della classe 1-A, comunica subito agli studenti che potrà espellerli in qualsiasi momento se non saranno all’altezza, salvo poi reintegrare gli espulsi a scopo formativo. Questo metodo “duro ma giusto” – sebbene estremo – trasmette agli allievi la serietà della missione eroica, ponendo aspettative elevate e stimolandoli a dare il massimo. In termini educativi reali, possiamo accostare questa filosofia all’idea di “alti standard e supporto”: sfidare gli studenti con obiettivi ambiziosi, fornendo però le risorse e il feedback necessari perché vi tendano (richiamando il concetto di zone of proximal development di Vygotskij, in cui l’allievo può progredire oltre il suo attuale livello grazie all’assistenza di una guida esperta).
Figura 1: Il corpo docenti della U.A. High School è composto da Pro Hero esperti (da sinistra, alcuni insegnanti: Thirteen, Cementoss, Snipe, Present Mic, Shota Aizawa, Midnight, ecc.), i quali portano in aula la loro esperienza sul campo. Questa miscela di competenze professionali e ruoli educativi caratterizza il metodo formativo unico della U.A.
Dal punto di vista curriculare, la U.A. offre sia materie tradizionali (matematica, lingua, scienze, ecc.) sia un robusto programma di Heroics, ossia lezioni pratiche per imparare il mestiere dell’eroe. Gli studenti del corso eroi seguono un orario intensivo con moduli aggiuntivi di addestramento tecnico-tattico. Grande enfasi è posta sull’apprendimento esperienziale: invece di limitarsi alla teoria, gli allievi affrontano simulazioni e prove sul campo sin dai primi mesi. Un esempio lampante è la simulazione di salvataggio presso l’USJ (Unforeseen Simulation Joint), una vasta area-attrezzata dove i ragazzi devono esercitarsi a gestire disastri e salvare civili sotto la supervisione dell’eroe astronauta Thirteen. Allo stesso modo, gli esami pratici di fine semestre consistono in missioni simulate (come scontri 2-contro-1 in cui coppie di studenti affrontano i loro insegnanti, addestrandosi alla collaborazione sotto pressione). Questo approccio learning by doing ricorda le teorie attivistiche di John Dewey e il concetto di apprendimento situato: i ragazzi imparano facendo, in contesti che riproducono la realtà professionale. Secondo il costruttivismo (Piaget, Bruner), l’apprendimento autentico avviene quando lo studente costruisce conoscenza attraverso l’esperienza diretta e la riflessione su di essa – esattamente ciò che avviene quando Deku e compagni rivedono i propri errori dopo ogni esercitazione, migliorandosi di volta in volta.
Un aspetto interessante del metodo U.A. è la combinazione di competizione e collaborazione. Ogni anno si tiene lo Sports Festival, un torneo scolastico a eliminazione diretta divenuto evento nazionale, seguito dal pubblico e dai Pro Hero in cerca di nuovi talenti. Tutti gli studenti (corso eroi, ma anche generico e support) partecipano mostrando le proprie abilità: per gli aspiranti hero è un’opportunità di mettersi alla prova in pubblico e farsi notare per ottenere tirocini e proposte di affiancamento da parte di agenzie di eroi professionisti. Al tempo stesso, la U.A. incoraggia il miglioramento personale più che la mera vittoria: lo testimonia il fatto che all’esame d’ingresso non venivano conteggiati solo i “villain robot” sconfitti, ma anche i punti salvataggio ottenuti aiutando gli altri – criterio grazie a cui Izuku, pur avendo zero punti di combattimento, viene ammesso per aver rischiato la vita salvando un compagno. Il messaggio didattico è chiaro: non conta solo primeggiare, ma dimostrare altruismo, capacità di lavorare in squadra e valori etici, coerentemente con la vocazione dell’eroe. In quest’ottica, la scuola bilancia competitività e cooperazione: se da un lato i ranking e i tornei spingono a superare i propri limiti (Plus Ultra! è non a caso il motto ufficiale della U.A.), dall’altro gli studenti imparano che un vero eroe sa collaborare e anteporre il bene comune alla gloria personale. Questa filosofia ricalca il mindset di crescita di Carol Dweck: l’attenzione è sul progresso di ciascuno, sul miglioramento continuo e sulla volontà di imparare dagli errori, piuttosto che su un’idea fissa di talento innato. Non a caso molti personaggi all’inizio arroganti o con mentalità fissa – basti pensare a Katsuki Bakugo, competitivo fino al disprezzo verso i “deboli” – attraverso le esperienze alla U.A. maturano umiltà e comprendono il valore di apprendere dagli altri. La cultura della resilienza permea dunque il metodo U.A.: fallimenti, difficoltà e pericoli vengono affrontati come parte del percorso, affinché gli studenti sviluppino la tenacia necessaria al compito eroico. Come affermano gli studi sulla resilienza in psicologia, “non si tratta di essere immuni dai fallimenti, ma di come li si affronta e se ne esce rafforzati”.
In sintesi, la U.A. funge da laboratorio educativo d’avanguardia: i docenti-eroi adattano liberamente la didattica (approccio personalizzato e non standardizzato), gli studenti imparano attraverso sfide reali con feedback immediato, e l’ambiente scolastico valorizza sia la motivazione intrinseca (la vocazione a proteggere gli altri) sia competenze socio-emotive come il lavoro di squadra, la leadership e la gestione dello stress. Molti di questi elementi rispecchiano principi noti nelle scienze della formazione: la pedagogia attiva, il cooperative learning, il tutoraggio (mentorship), la creazione di “situazioni problema” stimolanti (teorizzate da Bruner) e il supporto entro la zona di sviluppo prossimale (Vygotskij) per spingere i ragazzi “un passo oltre” le proprie capacità attuali. La U.A., insomma, incarna il motto “Go Beyond, Plus Ultra!” – Vai oltre, più in là! – incoraggiando gli studenti a superare costantemente i propri limiti attraverso impegno ed esperienza.
All Might: un mentore simbolico e formativo
Se la U.A. rappresenta la struttura educativa, All Might – alias Toshinori Yagi – ne è il cuore ispiratore. All Might, presentato inizialmente come il leggendario Hero No.1 e “Simbolo della Pace”, assume nella storia anche il ruolo di insegnante di Studi Eroici presso la U.A.. Più ancora che per il contenuto delle sue lezioni formali, egli è fondamentale come mentore e modello per la giovane generazione di eroi. La sua figura incarna quei docenti carismatici che, con la sola presenza e l’esempio, riescono a motivare gli studenti ad aspirare alla loro massima realizzazione. In pedagogia, Albert Bandura ha descritto bene l’importanza del modeling: gli individui apprendono osservando un modello di successo, soprattutto se ne ammirano competenza e valori. All Might è esattamente quel genere di modello: i suoi allievi (e la società intera) vedono in lui l’ideale dell’eroe altruista, coraggioso e incrollabile, e sono spinti a emularlo. Anche un villain come Stain riconosce che “solo All Might merita davvero il titolo di eroe, per la sua purezza morale e la giustizia incrollabile che beneficia davvero tutta la società senza legami col profitto”. Questa citazione paradossale (un nemico che elogia All Might) evidenzia quanto potente sia il valore simbolico di All Might: rappresenta un orizzonte etico a cui tendere. Per gli studenti, avere ogni giorno in classe il “Simbolo della Pace” in persona equivale ad una lezione vivente su cosa significhi essere un vero eroe.
Dal punto di vista formativo, All Might agisce su più livelli. In primo luogo, c’è la dimensione motivazionale-affettiva: il suo approccio è incoraggiante e positivo. Famoso per il suo sorriso invincibile e l’entusiasmo travolgente, egli infonde speranza anche nelle situazioni più disperate. In classe e negli allenamenti è di sostegno morale, lodando i progressi e ricordando agli studenti perché hanno intrapreso quella strada – ovvero proteggere il prossimo. Questo richiama il concetto di “persuasione verbale” nella teoria dell’auto-efficacia di Bandura: le parole di fiducia di una figura significativa possono rafforzare la convinzione del discente nelle proprie capacità. Un momento cruciale è quando All Might, dopo aver visto Izuku lanciarsi in aiuto di Katsuki Bakugo senza poteri, gli dice: “Puoi diventare un eroe”. Quella semplice frase ha un impatto potentissimo su Deku, alimentando in lui la fiducia (prima quasi assente) di poter riuscire: è un esempio concreto di come il feedback di un mentore possa attivare la motivazione intrinseca e la self-efficacy di un allievo. Bandura insegna che le convinzioni di efficacia personale si costruiscono attraverso successi padroneggiati, esperienze vicarianti (osservare modelli), incoraggiamento sociale e stati psicofisici positivi. All Might fornisce a Deku tutti questi ingredienti: inizialmente lo fa allenare duramente (permettendogli di vivere piccoli successi e miglioramenti concreti), gli offre il proprio esempio da seguire, lo incoraggia verbalmente nei momenti critici e gli trasmette calma e determinazione con il suo atteggiamento. Non sorprende quindi che Deku, col tempo, sviluppi una sempre maggiore fiducia in sé: “affrontando le avversità, inizia a credere nelle proprie capacità di eroe”, incarnando proprio il modello di crescita dell’auto-efficacia banduriana.
In secondo luogo, All Might fornisce un insegnamento etico e identitario. Oltre alle tecniche, trasmette valori. Durante lo Sports Festival, ad esempio, offre un colloquio di mentorship a Shoto Todoroki aiutandolo a capire che usare il proprio potere non significa diventare come il padre che odia, ma affermare se stesso. Qui All Might agisce da guida morale: ascolta il conflitto interiore dello studente e gli dà una nuova prospettiva, sbloccandolo. In termini di psicologia umanistica, potremmo dire che funge da facilitatore dell’autorealizzazione: come un buon counselor rogersiano, crea uno spazio di accettazione positiva e lo aiuta a chiarire i propri valori. Anche con Katsuki Bakugo, dopo che questi subisce un duro colpo al proprio ego (sentendosi responsabile del ritiro di All Might), Toshinori lo prende da parte per un confronto sincero, riconoscendo i sentimenti del ragazzo e guidandolo a convogliare la propria rabbia in determinazione costruttiva. Sono esempi di quella che potremmo definire tutorship socio-emotiva: All Might non si limita all’addestramento fisico, ma forma il carattere dei suoi allievi, insegnando umiltà, altruismo e controllo di sé – qualità fondamentali per un eroe maturo.
Infine c’è la dimensione simbolica e di visione. All Might incarna un ideale destinato però a essere superato: egli stesso, consapevole di non poter durare per sempre, incentiva i giovani a andare oltre lui (in modo molto diverso da certi maestri gelosi del proprio primato). Il suo motto personale – “Il tuo turno”, rivolto a Deku – segna il passaggio di testimone. In questo, All Might rappresenta il mentore generativo per eccellenza: come il saggio di tanti racconti (dal maestro Yoda di Star Wars a Silente di Harry Potter), sa farsi da parte al momento giusto perché l’allievo sbocci autonomamente. In pedagogia questo è l’obiettivo ultimo: rendere l’allievo autonomo e capace di fare a meno del maestro. Richiamiamo qui il concetto di scaffolding (Bruner): il mentore offre inizialmente un’impalcatura di sostegno, che viene gradualmente rimossa man mano che il discente conquista padronanza. All Might allena Deku per 10 mesi prima di cedergli il Quirk One For All, poi lo segue al liceo ma progressivamente interviene sempre meno nei suoi combattimenti, fino a limitarsi a consigliare o osservare, lasciando che Deku trovi da sé le soluzioni. Questo ritiro graduale è intenzionale: All Might vuole che il suo pupillo lo superi. Un’analisi pubblicata nota proprio che All Might non è un traguardo irraggiungibile, ma “un eroe dei eroi” progettato per essere superato, ed è questa la lezione che desidera trasmettere (un aspetto innovativo rispetto al mentore classico). In sostanza, come formatore All Might incarna un leadership educativo trasformativo: ispira attraverso l’esempio, sostiene lo sviluppo morale ed emotivo, e infine emancipa lo studente rendendolo protagonista. Il suo ruolo formativo va ben oltre la classe: nell’universo narrativo ha tenuto in piedi l’ordine pubblico per decenni solo con la sua presenza, mostrando quanto un singolo individuo carismatico possa influire sulla motivazione collettiva. Se trasliamo questo nella realtà, è un potente promemoria di quanto un educatore appassionato e “di valore” possa fare la differenza nella vita degli studenti, soprattutto in contesti difficili. Un buon mentore non solo trasferisce competenze, ma accende un fuoco interiore in chi lo segue – esattamente ciò che All Might realizza con Deku e con l’intera nuova generazione di eroi.
La motivazione di Izuku Midoriya: intrinseca, incrementale e resiliente
Il protagonista Izuku “Deku” Midoriya rappresenta un vero e proprio caso di studio motivazionale e di crescita personale. All’inizio della storia Izuku è un ragazzo privo di poteri in un mondo dove l’80% delle persone ne possiede uno – condizione che lo porta a essere scoraggiato e bullizzato. Eppure, Deku nutre un sogno intrinseco fortissimo: diventare un eroe per salvare le persone con un sorriso, come il suo idolo All Might. La sua motivazione nasce dunque da dentro, dalla passione e dai valori, non da incentivi esterni o imposizioni. In psicologia si parlerebbe di motivazione intrinseca: Izuku trova soddisfazione e senso già nell’aspirare all’obiettivo, nel piacere di sentirsi capace e utile. Questo tipo di motivazione è quella che, secondo Deci e Ryan (teoria dell’Autodeterminazione), sostiene l’impegno a lungo termine: basandosi su bisogni psicologici fondamentali come competenza (voler migliorare), autonomia (scelta personale) e relazione (desiderio di aiutare gli altri). Tutti e tre questi elementi si ritrovano in Deku. La competenza: Izuku studia instancabilmente gli altri eroi (compila quaderni di appunti strategici su ciascuno), si allena oltre ogni limite fisico quando All Might gli offre la chance di ereditare One For All, e continua a perfezionarsi giorno dopo giorno. L’autonomia: nonostante i pareri negativi (persino la madre e il medico da bambino gli consigliano di rinunciare al sogno, per non soffrire), è autodeterminato nel perseguire la sua vocazione; persino senza Quirk, si getta in azione per salvare Bakugo dall’attacco di un villain – gesto folle e non richiesto, segno di un senso di iniziativa personale fuori dal comune. La relazione: ciò che motiva Deku non è la fama o il voto scolastico, ma il desiderio profondo di aiutare gli altri in difficoltà (nel primo episodio dice: “essere eroe significa aiutare chi ha bisogno, anche a costo della vita”). Questa forte componente altruistica alimenta la sua perseveranza: come sottolinea la teoria, avere uno scopo prosociale dà significato allo sforzo e rende l’impegno sostenibile nel tempo. Deku incarna così l’idea che “la determinazione e la volontà di aiutare gli altri sono importanti quanto le abilità innate”.
Un altro aspetto chiave della crescita di Midoriya è il suo mindset di crescita e la sua resilienza. Carol Dweck definisce mindset di crescita quella mentalità per cui l’intelligenza e le capacità non sono fisse, ma possono svilupparsi attraverso sforzo, strategie e aiuto. Izuku ne è l’esempio lampante: lungi dal percepire i propri limiti come invalicabili, li affronta come sfide da superare con lavoro duro e creatività. Ogni battuta d’arresto diventa per lui un’occasione di apprendimento. All’inizio, incapace di controllare il potere di One For All, si rompe le ossa a ogni colpo – fallimento che avrebbe potuto farlo desistere. Invece, riflette (anche con l’aiuto dei docenti) su come migliorare: comprende i suoi errori, inventa nuovi approcci (ad esempio sviluppa lo Shoot Style per usare più le gambe delle braccia ormai compromesse, o impara a distribuire il potere in tutto il corpo al 5% invece che concentrarlo in un solo punto esplosivo). Questo continuo adattarsi e imparare dagli sbagli è la quintessenza del mindset incrementale. “Ottimismo e speranza” caratterizzano Deku anche nei momenti peggiori: egli crede sempre che con impegno e aiuto potrà farcela, e questa fiducia lo spinge a non mollare mai. Snyder, psicologo positivo, definisce la speranza come la convinzione che sia possibile trovare vie verso i propri obiettivi nonostante gli ostacoli. Deku possiede proprio questa convinzione, supportata dall’aver visto progressi concreti (prima entrare alla U.A., poi vincere sfide inizialmente impossibili). La ricerca sul mindset di crescita mostra che credere di poter migliorare le proprie abilità aumenta la perseveranza di fronte alle sfide – e Midoriya non rinuncia mai, neanche quando si trova molto indietro rispetto ai compagni più dotati.
Legata al mindset è la resilienza, ovvero la capacità di resistere e risollevarsi dalle avversità. Izuku affronta traumi fisici (infortuni ricorrenti, dolori, cicatrici permanenti alle mani) ed emotivi (senso di inadeguatezza, responsabilità immense per essere l’erede di All Might, pressione del dover salvare tutti). Eppure, ogni volta “persiste nonostante le avversità, imparando dai fallimenti e continuando verso i suoi obiettivi”. La resilienza, come notato dagli studi di Norman Garmezy e altri, non significa non cadere mai, ma sapersi rialzare più forti. Un episodio emblematico: durante l’esame per la licenza provvisoria da eroe, Deku fallisce nel salvataggio simulato di un bambino (viene criticato per non aver saputo tranquillizzare adeguatamente il piccolo). Questo colpo lo deprime, ma immediatamente lui ne fa tesoro: riconosce l’errore e, alla prima occasione successiva, dimostra di aver appreso adattando il suo approccio comunicativo. La curva di apprendimento di Deku è praticamente visibile agli occhi dello spettatore: caduta dopo caduta, il suo grafico di crescita punta sempre verso l’alto. In termini di educazione, questo è un fortissimo esempio dell’efficacia del feedback e della pratica deliberata: Midoriya cerca attivamente il feedback (chiede consigli a maestri come Recovery Girl, Gran Torino, Endeavor) e focalizza gli sforzi sulle sue debolezze per trasformarle in punti di forza. È quel processo che porta dall’incompetenza alla competenza attraverso tentativi, errori e correzioni successive – concetto caro sia alla didattica mastery learning sia alla psicologia cognitiva dell’apprendimento (il ciclo trial & error di Thorndike, o la pratica intenzionale di Ericsson nel costruire l’eccellenza).
Un ulteriore fattore che sostiene la motivazione di Deku è il supporto sociale. Nessuno cresce da solo, e Izuku beneficia enormemente di una rete di relazioni positive: All Might che crede in lui, l’amico-rivale Kacchan (Bakugo) che – pur spronandolo in modo duro – lo sfida a migliorarsi, gli amici come Ochaco Uraraka e Tenya Iida che lo sostengono emotivamente e cooperano nelle sfide, gli insegnanti che lo guidano. La teoria del social support (ad es. elaborata da psicologi come Julian Rotter) evidenzia che il sostegno emotivo e pratico delle proprie reti riduce lo stress e aumenta il benessere, facilitando la capacità di coping. Nel caso di Deku, vediamo chiaramente come avere qualcuno che lo incoraggia faccia la differenza: quando subisce una battuta d’arresto, una parola della madre, un gesto di un compagno o un ricordo di All Might sono spesso ciò che gli dà la spinta a non arrendersi. In un episodio, trovandosi temporaneamente isolato (durante l’Hero License Exam si allontana dagli amici), Deku realizza l’importanza di collaborare: unisce le forze con l’antico bullo Shinsou e con l’eroina conservativa Camie, mostrando di aver compreso che “insieme si va più lontano”. Questo rispecchia l’idea vygotskiana che l’apprendimento è un processo sociale: tramite l’interazione con pari e mentori, Deku raggiunge traguardi che da solo non avrebbe potuto (un chiaro esempio di zona di sviluppo prossimale: grazie all’aiuto degli altri colma il divario tra ciò che poteva fare da solo e ciò che riesce a fare in gruppo).
Volendo collegare Midoriya anche ad altre teorie, è interessante notare come incarni la self-efficacy di Bandura già citata: all’inizio la sua fiducia è bassissima (si definisce “Deku”, un soprannome dispregiativo che suona come “buono a nulla”), poi attraverso piccole vittorie (come salvare Ochaco nell’esame di ammissione, classificarsi bene al festival sportivo, ecc.) costruisce gradualmente la convinzione “posso farcela”. Bandura descrive proprio questo processo: le esperienze di successo, anche minori, creano un senso di efficacia che alimenta la motivazione. Deku sente di star diventando un eroe un passo alla volta, e ciò rinforza il suo impegno in un ciclo virtuoso. Possiamo citare anche la teoria dell’attribuzione di Weiner: Deku attribuisce i propri successi allo sforzo e all’apprendimento (fattori controllabili), e non a doti innate immutabili; quindi di fronte ai fallimenti non pensa “sono scarso e basta”, ma “non ci sono ancora riuscito, devo allenarmi di più” – un orientamento attributivo che favorisce la perseveranza. Inoltre, la sua vicenda ricorda il concetto di “grit” (determinazione e passione verso obiettivi a lungo termine, studiato da Angela Duckworth): Midoriya incarna un altissimo livello di grit, combinando passione (ama profondamente l’ideale dell’eroe) e perseveranza (non molla malgrado anni di difficoltà). Questo spiega perché, partendo svantaggiato, riesce col tempo a raggiungere e superare compagni inizialmente più dotati di lui.
In definitiva, Izuku Midoriya rappresenta in chiave narrativa ciò che le scienze psicopedagogiche suggeriscono riguardo alla crescita personale: motivazione intrinseca orientata da uno scopo nobile, mentalità di crescita che abbraccia le sfide come opportunità, resilienza nel fronteggiare ostacoli e riorganarsi dopo le sconfitte, e importanza delle relazioni di supporto nel sostenere il percorso. La sua evoluzione da ragazzo insicuro a eroe capace e leader carismatico è un inno al potere dell’educazione e dell’auto-miglioramento, dimostrando come anche chi parte svantaggiato possa eccellere se alimentato dalla giusta combinazione di impegno, guida e fiducia nelle proprie possibilità.
Conclusioni
Pur essendo un’opera di fantasia, My Hero Academia offre uno specchio stimolante di principi educativi e psicologici applicati. La U.A. High School ci mostra un modello formativo che privilegia pratica, innovazione didattica e sviluppo del carattere, ricordandoci l’importanza di scuole che sappiano andare oltre i metodi tradizionali per coltivare davvero il potenziale di ciascuno (talvolta “a qualunque costo”, verrebbe da dire, guardando la severità di Aizawa – ma il fine ultimo è temprarli alla realtà). La figura di All Might incarna il potere del mentoring e della leadership educativa: un solo insegnante-mentore ispirato può cambiare la traiettoria di molti giovani, trasmettendo non solo conoscenze tecniche ma anche fiducia, valori e una visione di ciò che possono diventare. Infine, la storia di Deku è una case history motivazionale da cui chiunque, anche fuori dall’ambito eroico, può trarre lezioni: l’idea che la passione e la dedizione contino più del talento grezzo, che ogni errore è un gradino verso il successo, che nessuno arriva al traguardo senza l’aiuto degli altri, e che credere in se stessi – o avere qualcuno che creda in noi – è spesso la profezia che si autoavvera del miglioramento. Tutto ciò riecheggia teorie consolidate: dal growth mindset di Dweck alla self-efficacy di Bandura, dal learning by doing di Dewey al supporto socio-culturale di Vygotskij, le avventure alla U.A. sono quasi un compendio narrativo di come avviene la crescita di una persona.
In un contesto divulgativo per formatori e educatori, My Hero Academia ci ricorda in forma metaforica ma efficace che educare eroi – ossia formare persone capaci di mettere i propri talenti al servizio della collettività – richiede un mix di metodo (curricula sfidanti, esperienze autentiche, feedback continui) e cuore (mentori appassionati, motivazione intrinseca, ideali che diano senso allo sforzo). In fondo, ogni docente potrebbe vedere un po’ di sé in All Might, nel suo sforzo di trasmettere il “quirk” (il sapere, i valori) alla prossima generazione sperando che vadano plus ultra. E ogni discente potrebbe rivedersi in Deku, con le proprie fragilità iniziali ma anche la capacità – con il giusto sostegno – di aspirare a qualcosa di grande e migliorarsi continuamente. La serie, dunque, pur intrattenendo, funge da catalizzatore di coraggio e superamento dei propri limiti, ispirando lo spettatore (e in particolare chi si occupa di crescita personale) ad affrontare le proprie sfide con rinnovata determinazione, andando oltre i propri limiti e credendo nel potenziale di trasformazione. In altre parole, My Hero Academia ci insegna che eroi non si nasce, ma si diventa – attraverso formazione, esempio e tanta perseveranza. Plus Ultra!